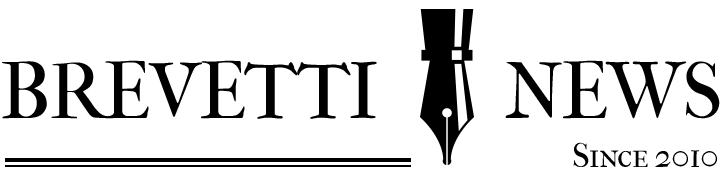Con il termine “look-alike” o “knock-off” si fa riferimento a quei prodotti che imitano, in modo più o meno marcato e talvolta addirittura pedissequo, l’aspetto esteriore di un altro, e, in particolare, l’insieme dei vari elementi che compongono la confezione del prodotto o la configurazione del prodotto stesso (contenitori, colorazione, etichettatura, rappresentazioni grafiche, slogan, lo stesso logo, etc.): il cd. “trade dress”.
Come si evince dalla terminologia adoperata, il fenomeno è stato studiato soprattutto dalla dottrina e dalla giurisprudenza nordamericana, anche se si sono registrate alcune pronunce pure in Italia.
Nella maggioranza dei casi l’imitazione ha ad oggetto prodotti ben conosciuti al pubblico dei consumatori e si tratta soprattutto di marchi notori: in genere, l’imitatore può proporli al mercato ad un prezzo inferiore, non avendo dovuto sopportare tutti i costi relativi alla ideazione, alla ricerca e sviluppo, all’industrializzazione, alla pubblicizzazione necessaria per imporre il nuovo articolo sul mercato, etc. In definitiva, dunque, egli consegue un’attenzione per i propri prodotti che altrimenti non avrebbe avuto.
Look alike: alcuni esempi
Il caso più ricorrente è quello delle grandi catene di supermercati che immettono sul mercato i prodotti “equivalenti” con sopra apposto il proprio marchio e oltretutto, potendo disporre della collocazione della merce sugli scaffali, si garantiscono una maggiore visibilità rispetto allo stesso prodotto “originale”.
Ora è chiaro che se l’imitazione ha ad oggetto elementi che sono protetti da un marchio, da un brevetto o da un disegno o modello industriale, essi saranno protetti dalla relativa disciplina. Il problema si pone in termini diversi in caso contrario.
L’ipotesi forse più frequente, a cui limitiamo l’analisi, è quella in cui l’insieme degli elementi che compongono la confezione del prodotto o la configurazione dello stesso costituiscono un marchio di forma di fatto. Condizione imprescindibile è che tali elementi abbiano funzione distintiva, permettano, cioè, ai consumatori di collegare un dato prodotto ad una certa impresa.
In passato, ci si è chiesti che tipo di tutela fosse possibile accordare al soggetto leso (considerati tutti gli investimenti, da lui sì, fatti) nei casi sopra descritti; le alternative possibili erano, infatti, due: da un lato, l’applicazione delle norme sul marchio registrato, con taluni adattamenti e, dall’altro, la disciplina della concorrenza sleale.
Look alike e concorrenza sleale
Nei rari casi giurisprudenziali finora registrati, secondo un certo orientamento, non c’è nessun rischio di confusione per il consumatore, ergo non c’è concorrenza sleale, se l’imitatore appone sulla confezione il proprio marchio. Laddove, al contrario si è concessa tutela al soggetto imitato, è stata ritenuta sussistente l’imitazione servile, con conseguente applicazione dell’art. 2598, n. 1 c.c.
E’ interessante rilevare che in tutte le pronunce riconducibili a questo secondo orientamento viene espressamente affermato che il confezionamento svolge una cruciale funzione distintiva (evidenziando che oltretutto è sulla confezione che vengono apposti i marchi di impresa) e attrattiva e che è la confezione che cade sotto la immediata percezione del consumatore. Naturalmente non sempre la confezione svolge una funzione distintiva: esso è un dato di fatto che deve essere accertato dal giudice, in caso di contestazione, ed in quelle ipotesi l’accertamento è stato positivo.
Altro dato interessante è che i giudici hanno ritenuto che, ai fini del giudizio di confondibilità, si dovesse procedere ad un esame unitario e sintetico dell’aspetto complessivo dei due prodotti in questione (quello imitato e quello imitante), e non di una comparazione analitica dei singoli elementi.
Anche la prima commissione di ricorso UAMI in una decisione del 20 dicembre 2000 (ric. Cabot Safety Intermediate Corporation) ha prestato attenzione al fenomeno e ha dato conto della diffusa pratica di produrre merce che ha la stessa forma e la stessa combinazione di colori di altri prodotti, ma con un marchio denominativo completamente diverso: soprattutto è interessante notare l’affermazione della commissione secondo cui tale condotta è adottata proprio perché gli imitatori sono perfettamente consapevoli del fatto che molti consumatori identificano i prodotti in base al loro aspetto generale, in particolare in base alla loro forma.
In una fattispecie esaminata dal Trib. Napoli, 11 luglio 2000 (causa Colussi Perugia SpA c. Elledì SpA), è stato scritto che, poiché la confezione del prodotto costituiva un marchio di forma di fatto, era evidente come la tutela invocata fosse la concorrenza sleale (contro l’imitazione servile ex art. 2598, n. 1 c.c.; anche se si aggiunge che non si possa escludere una qualche “interferenza” con il n. 2). Tuttavia, bisogna tener presente che la prospettazione difensiva della Colussi era incentrata fin dal ricorso sulla violazione della normativa in materia di concorrenza sleale, senza alcun richiamo alla disciplina prevista per i marchi.
Allo stato attuale, tuttavia, il quadro giuridico è cambiato e sembra ben possibile invocare anche la tutela prevista per il diritto di marchio; infatti, con il nuovo Codice della Proprietà industriale (D. Lgs. N. 30/2005) è prevista espressamente la protezione anche dei cd. diritti non titolati (art. 2 CPI) e questa è proprio una delle innovazioni più significative introdotte rispetto alla previgente disciplina. In particolare, il comma 4 dell’art. 2 CPI fa espresso riferimento, fra l’altro, al marchio non registrato.
Questo dato normativo ha indotto ad affermare, da parte di autorevole dottrina, l’applicabilità delle sanzioni e delle misure cautelari previste in materia di marchio registrato.